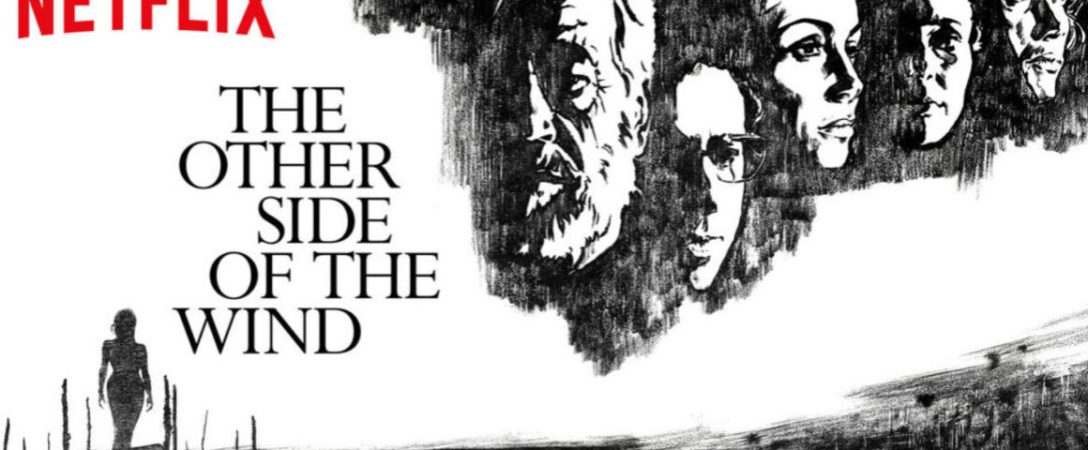Quando ero ragazzo, si pensava a The other side of the wind come a qualcosa di mitico. Nessuno credeva di poterlo vedere: ci contentavamo di conoscerne la trama e di sapere che Peter Bogdanovich lo considerava “tra le cose più affascinanti di Welles”. Era il film perduto, il capolavoro che nessuno avrebbe mai visto, per il quale credevamo sulla fiducia che si trattasse di un capolavoro.
Welles lo aveva montato in gran parte, aveva tentato e ritentato di terminarlo, sperava di poterlo far uscire, e aveva perfino chiesto a Bogdanovich di completarlo lui se gli fosse accaduto qualcosa. In effetti, qualcosa accadde: la notte del 10 ottobre 1985 il settantenne regista, ormai obeso e malato di cuore, morì d’infarto abbracciato alla sua macchina da scrivere, mentre lavorava a una sceneggiatura.
Nessuno poteva immaginare che la tenacia di Peter Bogdanovich avrebbe avuto la meglio, dopo quasi quarant’anni, sugli ostacoli economici e sui disaccordi legali tra Beatrice Welles, figlia del regista, e Oja Kodar, l’ultima compagna oltre che interprete del film. Né tantomeno potevamo prevedere che una cosa chiamata Netflix si sarebbe impegnata nel completamento mettendo a disposizione capitali e tecnologie all’avanguardia.
E così, oggi possiamo vedere The other side of the wind. Il mito si materializza, il capolavoro perduto diventa un film ritrovato. E cosa vi troviamo?
Bogdanovich ha ragione: è un’opera affascinante. Alcune scene sono visivamente tra le più belle e sontuose di Welles, anche se lo stato di conservazione della pellicola -a dispetto della profusione tecnologica- non permette di goderle sempre appieno. Quello che possiamo vedere è un film fra i più originali di Welles, in anticipo sull’estetica degli anni in cui è stato girato -1970-76- e proiettato verso il postmoderno, verso il mix di materiali eterogenei tipico del postmoderno, verso l’onnipresenza dei dialoghi tipica del postmoderno, verso lo stile “sporco” e frenetico del postmoderno.
Non sono mai stato un wellesiano che adora Citizen Kane. Il mio film preferito è un film tardo, F for Fake, sorta di documentario vicino, per concezione e stile di montaggio, a The other side of the wind. Chiaramente Bogdanovich e Netflix hanno preso a modello il suo stile. Ma forse era uno stile più adatto a un documentario che a un film dotato di una complessa articolazione drammatica. La musica di Michel Legrand, misto di jazz e classica sinfonica, è bella in sé, ma completamente slegata dall’architettura drammatica del racconto, e produce un effetto straniante che talvolta riesce magnifico, talaltra fastidioso -soprattutto su quelle scene, come quella delle candele, su cui Welles ha chiaramente profuso il suo gusto dell’illusionismo e del mistero, e in cui ci si sarebbe aspettati un po’ di fascino. Un altro elemento di disturbo è la qualità discontinua del sonoro: si avverte chiaramente che la colonna musicale è più recente della colonna dialoghi, e in quest’ultima si distingue perfettamente la voce originale di John Huston da quella del figlio che lo imita nel ridoppiaggio delle parti danneggiate.
Ma forse Welles non si sarebbe arrabbiato per questo, né per la mancanza di tensione narrativa, che rende alla lunga un po’ piatto il montaggio di Bogdanovich. La cosa che lo avrebbe fatto infuriare è che Netflix -vista “in 190 Paesi” come insegna l’ultimo film di Moretti- ha fatto a The other side of the wind quello che la RKO fece a L’orgoglio degli Amberson: ha cercato di rendere più rassicurante un prodotto nato inquietante, sopprimendo quasi metà della scena di sesso in auto -dove il corpo superbo di Oja Kodar è trasformato dallo sguardo del regista in corpo sacro e corpo sacrificale. Sappiamo che nel montaggio originale quella scena durava sette minuti, mentre nel rifacimento di Netflix ne dura solo tre.
Eppure, a dispetto di tutto, Welles arriva. Ci sono tutti i suoi marchi di fabbrica: dalle angolazioni di ripresa impossibili agli abbondanti chiaroscuri. C’è il suo sarcasmo -qui veramente sfrenato, sia nei dialoghi sboccati che nel fare il verso a registi non amati, come Michelangelo Antonioni. Forse c’è perfino troppo Welles: un Welles che non deve più confrontarsi con le convenzioni linguistiche e morali del cinema classico, e può esplicitare tutto laddove prima poteva solo alludere. Ma non è che, così, si perde qualcosa?